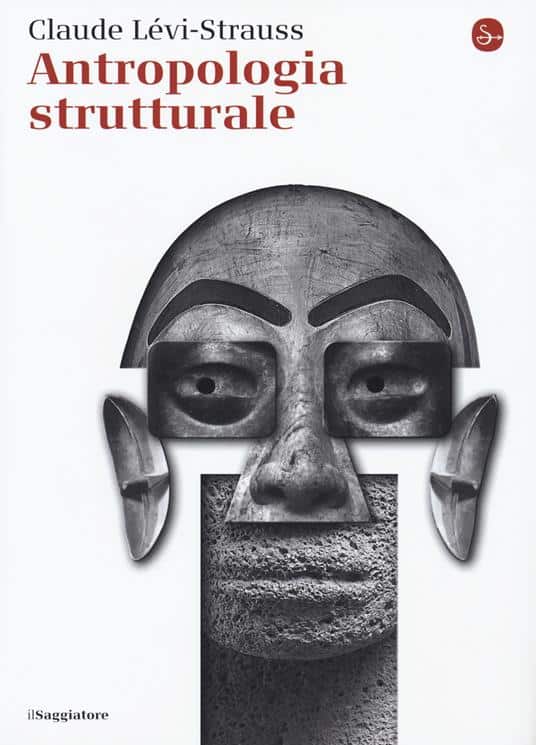Struttura del mito e attività mitopoietica del piccolo Hans[1]
Rossella Armellino
«Mine is a long and a sad tale» disse il topo rivolgendosi ad Alice, che osservandogli la coda rispose «It is a long tail, certainly[2]», non capendo, però, perché la chiamasse triste. Quella che Alice nel paese delle meraviglie si apprestava ad ascoltare, sebbene sulla base di un fraintendimento, era in effetti una lunga e triste storia, che lei immaginò a forma di spirale, da cui si sentiva trascinata senza riuscire a seguirne granché. Che il racconto, “tale”, sia contemporaneamente una coda, “tail”, un filo conduttore da seguire e da cui si è presi, ne aveva fatto esperienza anche un altro bambino, Hans, non frutto della fantasia di Lewis Carroll, ma figlio di un signore viennese seguace delle teorie del dott. Freud. Il piccolo Hans, all’età di cinque anni, fu colpito da una fobia per i cavalli e da quel momento si trovò avviluppato in una serie di fantasie sempre più complesse ed elaborate, con un finale da cui lo stesso protagonista ne uscì trasformato e liberato dai suoi timori, grazie ad una trovata inedita e del tutto particolare per il suo destino.
Le fantasie di Hans, diligentemente annotate dal padre del bambino, costituiscono il materiale su cui Freud lavorò, agendo in qualche modo da terzo rispetto alla coppia padre-figlio, per comprendere il senso dei sintomi fobici del suo piccolo paziente. È a questo testo, noto col nome di Analisi della fobia di un bambino di cinque anni, che Jacques Lacan, nel suo IV seminario[3], del 1956-1957, sulla relazione d’oggetto, dedica molte lezioni alla lettura del caso di Hans alla luce della teoria del significante. Contro la crescente psicologizzazione della pratica psicanalitica, Lacan cercava, in quegli anni, di ridefinire il campo inaugurato da Freud, l’inconscio, sgombrandolo da concezioni che ne facevano il luogo degli istinti o degli affetti, dotato di profondità, ma affermando, semplicemente, che «l’inconscio è strutturato come un linguaggio», e che esso insiste, senza per questo coincidervi, sulla stessa catena significante di cui è fatto il linguaggio umano. L’analisi del piccolo Hans mostra come ciò a cui mira il lavoro analitico non riguarda l’ipotetica maturazione del soggetto, attraverso il superamento degli stadi sessuali infantili fino a giungere al primato della sessualità genitale, né si riduce ad una tecnica diretta all’eliminazione del sintomo, volta, cioè, a educare e a far compiere un esame di realtà al soggetto, che acquisirebbe consapevolezza dell’infondatezza dei suoi comportamenti fobici. Essa è, invece, un percorso attraverso cui si dispiegano i significanti soggettivi, propri della storia individuale in cui ciascuno è da sempre iscritto, bloccati nella loro articolazione, in ciò che fa sintomo, affinché possano trovare il loro ordine nella struttura simbolica dell’inconscio.
Negli anni ’50 la linguistica e l’antropologia strutturale sono state due scienze di cui Lacan è stato fortemente debitore per la sua concezione dell’inconscio. Esse, infatti, avevano inaugurato un modo nuovo di studiare le manifestazioni umane, cercando di cogliere la variabile soggettiva, senza far riferimento né alla comprensione per via simpatetico-intuitiva, né alle spiegazioni d’ordine storico-sociale, per le quali gli individui sono effetti di queste sovrastrutture. Sia la linguistica che l’antropologia esaminano i fenomeni umani al pari di quelli naturali, individuandone le leggi che li governano, leggi che all’insaputa dei soggetti agiscono e costituiscono la vera realtà di tutte le attività umane, anche le più “libere” e creative.
Per ritornare al caso del piccolo Hans e della sua fobia, Lacan nel IV seminario analizza le produzioni fantastiche di Hans alla stregua dei miti delle popolazioni indigene studiate da Lévi-Strauss. Per l’antropologo i miti non erano considerati elaborazioni rozze tipiche di una civiltà arretrata, né espressioni dominate da sentimenti e da rappresentazioni mistiche, a differenza di quanto i principali orientamenti teorici in campo antropologico sostenevano. I funzionalisti, infatti, affermavano che i miti erano creati per rispondere al soddisfacimento di bisogni primari dell’esistenza e quindi a un principio d’utilità; per i simbolisti, erano invece tentativi per spiegare fenomeni difficilmente comprensibili, elaborati in chiave emotiva e religiosa. Lévi-Strauss, distaccandosi da queste due posizioni teoriche dominanti, si chiedeva come fosse possibile spiegare la presenza di racconti di avvenimenti casuali e illogici in miti di popoli diversi e lontani fra loro. Abbandonando la ricerca di tipo storico o psicologico-religioso, Lévi-Strauss intraprese così la strada già aperta dai linguisti strutturalisti, trovare cioè le invarianti alla base delle produzioni mitiche dei popoli primitivi, in altri termini i principi, che danno ordine all’insieme caotico delle diverse forme di racconto.
Nello studio e nell’analisi comparativa delle diverse mitologie Lévi-Strauss si avvalse di un procedimento che metteva da parte i significati particolari o nascosti che venivano attribuiti alle diverse narrazioni, allo stesso modo dei linguisti che avevano distinto la funzione significativa dai suoni, ossia la mancanza di affinità naturale fra un significato ed un suono (il concetto di albero e la parola “albero”). In Antropologia strutturale, egli paragona il mito proprio al linguaggio, ma a «un linguaggio che agisce a un livello elevatissimo, e in cui il senso riesce, per così dire, a decollare dal fondamento linguistico da cui ha preso l’avvio[4]». Se è vero che il mito è una struttura in cui prevale l’aspetto del senso, questo va considerato, «nel linguaggio, ma – precisa Lévi-Strauss – anche al di là del linguaggio[5]».
Un aspetto interessante della struttura del mito è che in esso funzionano non solo gli aspetti diacronici e sincronici (le trasformazioni storiche della lingua e la sua forma statica), tipici del linguaggio, ma anche un’altra forma temporale che fa riferimento contemporaneamente al passato, al presente ed al futuro. Gli avvenimenti narrati dal mito, che si immagina abbiano avuto origine nel tempo, danno vita a una struttura narrativa permanente, astorica, che agisce e ha effetti nel presente. Non solo, il valore del mito persiste contro ogni possibile alterazione o traduzione. In altre parole, non sorge il problema della versione autentica, la quale potrebbe confutare le altre, perché il mito con le sue varianti è sempre nel pieno del senso.
Per evidenziare l’ossatura in cui vanno a disporsi gli elementi, Lévi-Strauss, nel saggio “La struttura dei miti”, scompone il mito in unità costitutive, che chiama mitemi, differenziandole da quelle proprie della lingua: fonemi, morfemi, semantemi (rispettivamente unità minime fonetiche, grammaticali e semantiche). In pratica egli riduce il racconto mitologico in frasi minime, contenenti cioè, un soggetto ed un predicato, che denotano una forma di relazione. Questa operazione, tuttavia, non è sufficiente, le unità così ottenute sarebbero ordinate solo diacronicamente (la fabula, sebbene ai minimi termini). Occorre, invece, che le unità costitutive siano formate non da relazioni isolate, ma da fasci di relazioni. In questo modo esse verranno a disporsi simultaneamente nei due ordini diacronico e sincronico, come una partitura d’orchestra, che si legge in senso orizzontale e verticale, in cui ciascuna nota fa parte contemporaneamente dell’esecuzione di uno strumento solista e dell’armonia eseguita dall’orchestra.
Una volta assunta la nuova sistemazione, ecco che dal caos delle relazioni emerge un principio d’ordine che si fonda su operazioni logiche di tipo binario, ossia su un sistema d’opposizioni, che prolifera nelle sue varianti.
Qual è la novità di questo modo di leggere i miti in chiave strutturalista? Lévi-Strauss in Antropologia strutturale applica questo metodo al mito per eccellenza della nostra tradizione occidentale: il mito d’Edipo. Dopo averne isolato i mitemi, le frasi minime, li raggruppa secondo relazioni di somiglianza e li incolonna. Ottiene così una griglia in cui tutti i pezzi hanno il loro posto; infatti partendo da destra verso sinistra, dall’alto verso il basso, troviamo i mitemi secondo l’ordine della narrazione. Sugli assi verticali, invece, ci sono i mitemi che hanno tratti comuni. Inoltre, la relazione fra gli elementi di una stessa colonna è presente, col segno opposto, fra quelli della colonna successiva, e così via. Per facilitare la comprensione riproduciamo qui lo schema che fa Lévi-Strauss nel suo testo[6].
Nella prima colonna troviamo i seguenti mitemi: “Cadmo cerca sua sorella”, “Edipo sposa Giocasta sua madre”, “Antigone seppellisce suo fratello Polinice”; nella seconda, “Gli Sparti si sterminano vicendevolmente”, “Edipo uccide suo padre Laios”, “Eteocle uccide suo fratello Polinice”. Alla prima colonna appartengono, quindi, storie di legami di parentela sopravvalutati, alla seconda, al contrario, legami di parentela sottovalutati. Nella terza e quarta colonna sono raggruppati, rispettivamente, mitemi riguardanti mostri e loro distruzione da parte degli uomini, e uomini nati dalla terra rappresentati come zoppi o incapaci di camminare, evidenziando l’una la negazione e l’altra la persistenza dell’autoctonia dell’uomo.
Il mito d’Edipo, dunque è il tentativo, afferma Lévi-Strauss, di dare risposta all’origine dell’uomo da parte di una società che si trovava nella difficoltà a dover passare dalla credenza nell’endogamia al riconoscimento che si nasce dall’unione di un uomo e di una donna. Il problema, non è certo di poco conto, e se il mito può venire incontro per trovare una soluzione è per la sua forma, più che il contenuto. In altri termini, il mito funziona come una macchina, indifferente ai contenuti immaginari, la quale, per lavorare, ha bisogno d’inserire nel circuito elementi ridotti ad unità minime. Passando a dei riferimenti filosofici, il mito va pensato come dotato di una logica che offre la possibilità di pensare le contraddizioni senza cancellarle. Non si tratta di una logica hegeliana, in cui le opposizioni, rese meno rigide e sottratte alla loro determinatezza, vengono conciliate in una figura di ordine superiore. Il mito, in realtà è più vicino alle “idee” kantiane, che alla dialettica e al movimento dell’Aufhebung. Le “idee” kantiane, non sono leggi, categorie, che l’intelletto produce per regolare i fenomeni e dominare la realtà, ma sono espressione di un’altra facoltà, la ragione, che in qualche modo…sragiona, dice “fesserie[7]”. Essa estende, infatti, in modo surrettizio le categorie dell’intelletto a ciò che non è del mondo sensibile, per poter pensare la totalità e l’incondizionato. La ragione non offre una conoscenza più profonda dei fenomeni, ma si limita a fornire degli “ideali”, ossia delle simbolizzazioni incommensurabili alla realtà, che guidano l’azione umana[8].
Il mito, allora, proprio per il fatto di presentarsi come un “ideale”, non toglie le contraddizioni, che anzi permangono; tuttavia, pur non assumendo una forma definitiva, in quanto passibile di trasformazioni ed arricchimenti, non perde la sua “efficacia simbolica”. Il fatto che nei miti si riscontri la riproposizione di sequenze simili e la ripetizione degli stessi rapporti, rivela, secondo Lévi-Strauss, la matrice logica della mitopoiesi. Le sostituzioni e le combinazioni dei mitemi hanno luogo proprio perché non c’è un referente oggettivo, il mito, ricordiamoci, nasce per rispondere a un enigma. Pertanto, per riprendere le parole di Jacques Derrida, tale movimento è «reso possibile dalla mancanza, dall’assenza di centro o di origine, è il movimento della “supplementarità”». La «ridondanza» dei mitemi è ascrivibile, quindi, al fatto che «una carenza deve essere supplita»[9], ma ciò avviene non chiudendo il cerchio, attraverso una configurazione ultima e perciò totalizzante del mito, quanto piuttosto attraverso la continua messa in circolo dei suoi elementi.
Fin qui l’antropologia strutturale, ritorniamo al caso del piccolo Hans, perché tanto interesse da parte di Lacan allo studio dei miti? Lévi-Strauss con la sua analisi strutturale aveva rivelato che i miti sono dei testi, delle tessiture, che rompono con la categoria della “comprensione”, per il fatto stesso che rispetto a essi gli uomini primitivi non si pongono nell’atteggiamento di chi vuole capire, conoscere, ma sono essi stessi “compresi” in ciò che i miti raccontano e sono parte in causa del legame sociale che viene così istituito[10].
Le fantasie di Hans, prodotte in seguito allo scoppio della fobia, sono lette da Lacan allo stesso modo con cui Lévi-Strauss aveva operato con i miti. Il cavallo, ossia l’animale su cui si concentrano le paure di Hans, non va considerato, quindi, come qualcosa dotato di una sua identità, a cui è possibile attribuire dei significati, ma va inteso semplicemente come una variabile, una x, un significante all’interno di un sistema più ampio. D’altronde che non sia la “cavallinità” ad essere in questione ce lo dimostra lo stesso Hans, il quale in fondo non ha paura di tutti i cavalli, ma soltanto di quelli con certe caratteristiche, neri e che corrono o partono all’improvviso. Il cavallo mostra di avere la funzione di poter trascinare dietro di sé ben altro, di essere polo d’attrazione per altri significanti che così possono entrare in gioco.
La paura dei cavalli, ci fa notare Freud, non è originaria, il timore da parte di Hans di essere morso per strada da uno di essi, scoppia solo dopo l’emergenza di stati d’angoscia. L’angoscia, che di per sé è priva d’oggetto, si trasferisce in un secondo momento sui cavalli, agganciandosi ad essi, come un rimorchio, diventando, in tal modo, paura localizzata. È dal momento in cui si manifesta la paura dei cavalli che prende avvio il “mito” di Hans. Ciò che è interessante notare, dice Lacan, è che queste fantasie non sono delle intellettualizzazioni, delle attività intenzionali. Se, infatti, il lettore prova un certo smarrimento nel seguire i tortuosi sentieri, su cui s’inerpicano i pensieri del piccolo, a maggior ragione lo è Hans che non sa quello che dice. Egli è conscio del non senso delle “sciocchezze” che racconta al padre, tanto da scherzarci su, da farci dei witz, testimoniando di partecipare più nei panni d’attore che di autore delle “sue” fantasie. Tuttavia, non per questo non prende tali “sciocchezze” molto sul serio, come pure suo padre, che va a raccontarle, a sua volta, al dott. Freud.
Il cavallo, allora, funzionando da innesco fa aggregare attorno a sé altri pensieri (Hans ci tiene a sottolineare che ciò che riferisce sono pensieri e qualche volta sogni), in cui compaiono elementi nuovi e situazioni sempre più complesse. Lacan seguendo le affabulazioni del bambino individua alcune costanti nella narrazione, i termini in gioco a partire dal cavallo, dalle vetture ferroviarie alla vasca da bagno, dalla giraffa al temperino, hanno in comune il tratto distintivo di poter cambiare attraverso: il movimento, la sostituzione o la duplicazione (la giraffa scritta e accartocciata, il temperino che entra ed esce dalla bambola). Inoltre come agenti di tali trasformazioni scendono in campo vari personaggi, tra cui la sorellina Hanna, che riesce a cavalcare il cavallo, e lo stagnaio che con le sue pinze sostituisce il popò di Hans dandogliene uno nuovo. Come le tessere di un mosaico, gli elementi delle fantasie si combinano fra loro fino a trovare una composizione che tiene, in cui tutti i pezzi sono ben messi, compreso Hans, che, finalmente, trova il suo posto all’interno dell’ordine di parentela, anche se del tutto particolare.
La fobia di Hans, come il mito, sorge, come sarà ormai chiaro al lettore, per rispondere a una impasse. Nella vita di questo bambino, dopo che aveva già fatto irruzione la pulsione sessuale e avvenuta la nascita della sorellina Hanna, viene a rompersi il gioco di farsi il fallo della madre ed è costretto a confrontarsi col fatto doloroso di non essere più niente per lei, dal momento che il suo pene viene apostrofato di “sudiceria”. Tutto l’armamentario delle fantasie viene, così, smobilitato per supplire alla carenza della funzione paterna. Se fino a quel momento la vita di Hans era all’insegna di una certa pienezza, di un eccitante e soddisfacente rapporto con la madre e i suoi compagni di gioco, il venir meno del suo ruolo di “falloforo” lo pone in uno stato in cui tutto viene a vacillare. Laddove, di norma, è il padre che interviene, presso il figlio, col divieto di occupare un posto che non compete al bambino, ma anche con la promessa che un giorno anche lui potrà essere come il padre, e, presso la madre, per spezzare il circolo ristretto ed asfissiante madre-bambino, nel caso di Hans questo non si realizza. Il suo desiderio rimane inserito nel circuito materno, senza subire l’interdizione paterna. È un Edipo senza rimozione, ossia, «senza complesso di castrazione o con un complesso di castrazione in attesa[11]». Il padre di Hans è un padre moderno, affettuoso, gentile, la cui presenza e parola non determinano però alcun effetto simbolico sul bambino, la fobia risulta essere, così, l’unica via d’uscita per sviluppare un sintomo e mettere in piedi una struttura che non solo gli eviti l’angoscia di essere fagocitato dalla madre, ma che gli consenta di poter assumere una sua identificazione e di investire libidicamente altri oggetti.
Hans al termine delle sue combinazioni significanti ha veramente risolto il problema della procreazione e la questione del padre? La struttura finale delle metamorfosi di Hans provano che egli ha cercato di fare a meno del padre, mettendo in posizione simbolica un’altra donna, la nonna paterna, a fare da garante alla procreazione. Riguardo alla sua identificazione sessuale, anche essa ne risulterà perturbata, assumendo da adulto, nei confronti delle donne, una posizione eterosessuale passiva. In mancanza del dono della castrazione, che avrebbe elevato il suo piccolo e risibile pene a simbolo fallico, iscrivendolo così nella catena simbolica delle generazioni, non potrà che oscillare fra l’essere il fallo della madre ed avere il fallo nei suoi oggetti[12].
[1] Una prima versione del presente articolo è stata già pubblicata nella rivista di psicoanalisi «Notes Magico», n. 7, Editrice Clinamen, Firenze, 2008.
[2] Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, ed. BUR, Milano, 1978, p. 90. Riportiamo qui la traduzione italiana «La mia non è una di quelle storie senza né capo né coda: è lunga e triste» «Lo so che la coda è lunga».
[3] Jacques Lacan, Il seminario. Libro IV. La relazione oggettuale 1956-1957, Einaudi, Torino, 2007
[4] Cl. Lévi-Strauss, La struttura dei miti, in Antropologie Structurale, Librairie Plon, 1964, Paris, tr. it. P. Caruso, Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano, 1990, p. 236.
[5] Ivi, p. 234
[6] Ivi, p. 240
[7] Il mito «è il campo delle fesserie. E dire fesserie, come vi dico da sempre, è la verità. È la stessa cosa.», in J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi. 1969-1970, Einaudi, 2001, Torino, p. 134-135.
[8] Rimandiamo per l’approfondimento dei concetti di “idea”, “ideale”, “simbolo”, al bel libro di B. Moroncini, Walter Benjamin e la moralità del moderno, Guida editori, Napoli, 1984, pp.324-330.
[9] J. Derrida, La struttura, il segno e il gioco, in L’écriture et la différence, Éditions du Seuil, Paris, 1967, tr. it. G. Pozzi, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino, 1982, pp. 372-373.
[10] Si rimanda al seminario Il rovescio della psicoanalisi, in cui Lacan inizia a formulare una teoria dei legami sociali che, a differenza di quanto ha fatto Freud, fa a meno di ogni riferimento all’identificazione al padre dell’orda primitiva di Totem e tabù, che si basa sempre sulla colpevolezza conseguente alla sua uccisione, e mette in gioco le permutazioni dei 4 discorsi.
[11] Vedi prefazione di M. Fiumanò a Hans 100 anni, «Quaderni lacaniani» – 1, Roma-Milano 2004, pubblicazione ad uso interno a cura della Scuola di Psicanalisi e del Laboratorio Freudiano di Milano.
[12] Siamo debitori per la lettura del caso del piccolo Hans oltre al testo di Lacan, degli interventi alla giornata di studio su La questione della Fobia nell’insegnamento di Jacques Lacan, 2 giugno 1993, organizzato da Cosa freudiana di Roma e dal Centro Lacaniano di Studi Psicoanalitici di Napoli.